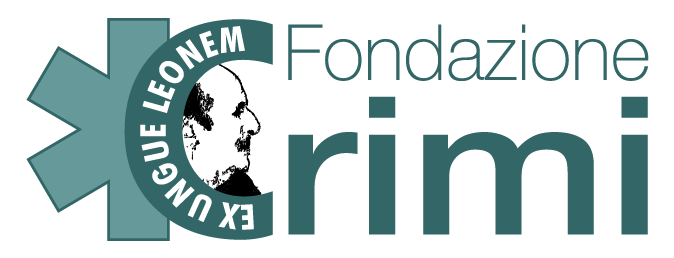DNA: una ricerca durata quasi un secolo
La storia della scoperta del DNA e della sua struttura è segnata da varie tappe, ognuna delle quali rappresenta un progressivo avvicinamento verso quella che sarà la pubblicazione di Watson e Crick nel 1953. Da allora sono stati fatti molti altri passi avanti circa il ruolo del DNA come materiale genetico e i meccanismi in cui è coinvolto.
La lunga storia degli acidi nucleici incomincia nel 1869 con un giovane ricercatore svizzero Johann F. Miescher. Questi, sotto indicazione del suo mentore, Felix Hoppe-Seyler, eminente biochimico dell’epoca, cominciò a interessarsi di globuli bianchi. Nel tentativo di separare dal nucleo dei globuli bianchi, contenuti nel pus di bende chirurgiche utilizzate nei vicini ospedali, componenti del citoplasma, si imbatté, dopo estrazione del materiale nucleare, in un composto che analizzò e scoprì che era acido e conteneva, tra l’altro, azoto (così come le proteine) e fosforo (elemento mai trovata nelle proteine note a quei tempi). Esperimenti condotti con cellule di tessuti diversi lo portarono, infatti, a ottenere gli stessi risultati. Miescher, quindi, arrivò alla conclusione che doveva trattarsi di una componente cellulare distinta, localizzata all’interno del nucleo e mai descritta prima, che egli chiamò nucleina. Purtroppo né Miescher né i suoi contemporanei apprezzarono pienamente il possibile ruolo della nucleina nella trasmissione dei caratteri ereditari. La comunità scientifica venne a sapere dell’esistenza del DNA per la prima volta nel 1871, grazie alla pubblicazione dello scienziato svizzero, ma il suo lavoro fu pressoché ignorato. Alla nucleina fu attribuita piuttosto una funzione di immagazzinamento del fosforo cellulare e non fu escluso del tutto che si potesse trattare di una miscela di fosfati e proteine.
Bisogna attendere l’inizio del Novecento per assistere ad un crescente interesse verso il DNA. Phoebus A. T. Levene identificò i componenti del DNA e formulò anche alcune ipotesi sulla sua struttura che si rivelarono solo parzialmente corrette. Mise in luce la disposizione dei componenti secondo la sequenza ripetuta fosfato – zucchero – base, unità che chiamò per la prima volta nucleotide, ed ipotizzò che le molecole di DNA non fossero altro che filamenti composti da nucleotidi collegati tra loro attraverso i gruppi fosfato, considerati lo scheletro del DNA stesso.
Le sue idee complessive sulla struttura del DNA non si rivelarono tuttavia corrette dal momento che riteneva che ci fossero solo quattro nucleotidi per molecola e, per tale motivo, escluse che il DNA potesse essere il vettore dell’informazione genetica, in quanto era ritenuta una molecola troppo semplice per tale scopo. Nel 1910, formulò l’ipotesi del tetranucleotide (vedi foto), che proponeva che il DNA fosse costituito da quantità eguali di adenina, guanina, citosina e timina. Secondo la teoria del tetranucleotide , gli acidi nucleici erano composti da soli quattro nucleotidi (due purinici e due pirimidinici) e quindi data la loro monotona struttura e le loro ridotte dimensioni non potevano essere il supporto molecolare dell’ereditarietà biologica. Anche se tale teoria rappresentò uno degli indugi più gravi nell’accettare l’importanza del DNA nella genetica, a Levene spettò tuttavia il credito per aver introdotto i termini “nucleotide” e “nucleoside” e la scoperta che i nucleotidi erano legati fra loro per mezzo di legami fosfodiesterici tra gli ossidrili OH in posizione 5’ e 3’ come venne in seguito confermato dal chimico scozzese Alexander R. Todd, il quale dedicò gran parte delle sue ricerche alla struttura e alla sintesi dei nucleotidi e dei nucleosidi.
Fu solo con David W. Griffith, però, che vennerò poste le basi per una precisa determinazione del materiale genetico. Egli dimostrò che ceppi di Diplococcus pneumoniae o Pneumococco ( il cui nome scientifico attuale è Streptococcus pneumoniae) uccisi al calore possono trasformare un ceppo virulento in non virulento. Tale esperimento, del 1928, aprì la strada alla determinazione della natura del materiale genetico. Griffith utilizzò due varianti dello Streptococcus pneumoniae. La prima variante presenta batteri di ceppo S o liscio in quanto produttori di colonie lisce e lucenti per la presenza di una capsula che avvolge la cellula batterica; tale variante viene anche detta “ ceppo capsulato” ed è in grado di provocare la polmonite. La seconda variante presenta batteri di ceppo R o rugoso dal momento che producono colonie dall’aspetto rugoso per l’assenza della capsula batterica e non in grado di provocare la polmonite cioè non patogena. Utilizzando dei topi in cui venivano iniettati i batteri, egli verificò e dimostrò che:
- iniettando il ceppo patogeno, i topi contraevano la malattia e morivano poco dopo. Inoltre era possibile isolare batteri S dai tessuti dell’animale.
- Iniettando invece il ceppo R non si manifestava la malattia, ma non era possibile isolare batteri R dai tessuti dell’animale.
- Neppure l’Iniezione del ceppo S, ucciso in seguito a trattamento termico, causava malattia e neppure in questo caso era isolabile dai tessuti dell’animale-
- Iniezione in topo di una miscela di batteri S uccisi in seguito a trattamento termico e di batteri R vivi era in grado di provocare malattia e morte dell’animale. Dai tessuti del topo si potevano isolare batteri vivi del ceppo S.
Griffith intuì, quindi, che dalle cellule batteriche inattivate qualche sostanza doveva essere trasferita a quelle innocue ed che era in grado di conferire ad esse le caratteristiche di patogenicità. Egli definì questa sostanza non identificata “Fattore Trasformante”. Come la maggioranza degli scienziati di quel tempo, ritenne erroneamente che quella fosse di natura proteica. Studi successivi ed anni di ricerche portarono poi a stabilire che questo “fattore modificante” non era altro che il DNA.
Nel 1944 il biologo americano Oswald Avery ed i suoi colleghi Colin M. MacLeod e Maclyn McCarty dimostrarono, infatti, che il “fattore trasformante” di Griffith era il DNA (anche se la prova definitiva arriverà solo dagli esperimenti di Hershey e Chase del 1953). Questi a partire da Streptococchi pneumoniae di tipo S ( lisci e virulenti) fecero un estratto o lisato cellulare in modo da ottenere una soluzione nella quale era disciolto il materiale contenuto nei batteri. Il materiale genetico doveva presumibilmente essere uno dei diversi tipi di macromolecole biologiche presenti nei batteri: (proteine, polisaccaridi, acidi nucleici – ossia DNA e RNA – e lipidi). Infatti, essi cercarono di capire quali di queste sostanze erano effettivamente in grado di trasformare batteri di ceppo R (ruvidi e avirulenti) in batteri di ceppo S virulenti. Se si distruggevano gli acidi nucleici del campione, l’attività di trasformazione andava persa, ma ciò non avveniva quando si distruggevano le proteine, i carboidrati o i lipidi: il materiale genetico doveva quindi essere DNA e/o RNA.
Per capire quale delle due sostanze fosse, divisero l’estratto contenente l’acido nucleico in due aliquote: la prima, venne trattata con l’enzima ribonucleasi (RNAsi) che degrada selettivamente l’RNA e non il DNA; la seconda, venne invece trattata con deossiribonucleasi (DNAsi) che degrada selettivamente il DNA e non l’RNA. Ciò che osservarono era la trasformazione dei batteri R in batteri S solo in seguito all’aggiunta dell’aliquota trattata con RNAsi. Il materiale genetico doveva allora essere necessariamente il DNA, in quanto il principio trasformante era sensibile solo alla DNAsi.
Le conclusioni dell’esperimento di Avery e colleghi furono le seguenti: a) Un estratto di batteri di ceppo S non contiene più batteri vivi e pertanto non dà origine a colonie. b) I batteri di ceppo R non trattati danno sempre origine a colonie piccole e di tipo R. c) Un estratto di batteri S aggiunto a batteri R vivi può dare origine a colonie di tipo S. d) Un estratto di batteri S nel quale il DNA sia stato eliminato per digestione enzimatica perde la capacità di dare origine a colonie di tipo S. e) Trattamenti dell’estratto di batteri S con enzimi che degradano altre macromolecole non determinano perdita dell’attività trasformante.
Oggi sappiamo che durante la trasformazione avviene il trasferimento del gene preposto all’enzima che catalizza la sintesi della capsula polisaccaridica dello pneumococco.
Gli esperimenti di Avery vennero criticati dagli scienziati dell’epoca in quanto in quel periodo vi era la convinzione che il materiale genetico doveva per forza essere di natura proteica. Infatti, pareva più sensata la natura proteica, perché in questo modo ci sarebbero state molte più combinazioni tra i vari monomeri (nel caso delle proteine i monomeri erano i 20 aminoacidi mentre nel caso del DNA i monomeri erano costituiti dai soli 4 deossiribonucleotidi) rispetto agli acidi nucleici. Sotto la spinta di queste convinzioni, quello che fu criticato ad Avery era la non completa purezza degli acidi nucleici utilizzati nell’esperimento: all’interno delle soluzioni contenenti DNA e RNA si ipotizzava fossero presenti anche tracce di proteine, le stesse proteine che gli scienziati scettici pensavano costituissero il materiale genetico.
Pur non tralasciando l’importanza dell’evidenza sperimentale, non si può dire che l’esperimento di Avery , MacLeod e McCarty fosse la prova definitiva. Solo una più tardi nel 1953, Alfred D. Hershey e Martha Chase dimostrarono che il materiale genetico è costituito da DNA.
L’esperimento di Hershey e Chase, teso a stabilire se il materiale genetico fosse il DNA o le proteine, fu eseguito su un virus che infetta i batteri. Questo virus, detto batteriofago T2, è composto da poco più che un cuore di DNA impacchettato in un rivestimento proteico, proprio i due materiali all’epoca maggiormente sospettati di essere il materiale genetico. Quando un batteriofago T2 attacca un batterio, una parte del virus (ma non tutto il virus) penetra nella cellula batterica. Circa 20 minuti dopo l’infezione, la cellula va incontro a lisi e libera decine di particelle virali. Evidentemente il virus è in qualche modo capace di riprodursi all’interno del batterio. Hershey e Chase ne dedussero che l’ingresso di una qualche componente virale agisse sul programma genetico della cellula batterica ospite, trasformandola in una fabbrica di batteriofagi. Si accinsero quindi a stabilire quale parte del virus, la proteina o il DNA, penetrasse nella cellula batterica. Per rintracciare le due componenti del virus lungo il suo ciclo vitale, i due ricercatori le marcarono con isotopi radioattivi selettivi:
- Le proteine contengono zolfo (negli amminoacidi cisteina e metionina), un elemento che non compare nel DNA. Lo zolfo presenta un isotopo radioattivo, 35S. Hershey e Chase fecero sviluppare il batteriofago T2 in una coltura batterica contenente 35S, in modo da marcare con questo isotopo radioattivo le proteine delle particelle virali risultanti.
- Il DNA è ricco di fosforo (nell’ossatura desossiribosio-fosfato), un elemento normalmente assente nelle proteine. Anche il fosforo presenta un isotopo radioattivo, 32P. Così i ricercatori fecero sviluppare un altro lotto di T2 in una coltura batterica contenente 32P, in modo da marcare con questo isotopo radioattivo il DNA virale.
Usando questi virus marcati con isotopi radioattivi, Hershey e Chase eseguirono i loro esperimenti. In un primo esperimento, i ricercatori lasciarono che i batteri, , nel loro caso Escherichia coli, venissero infettati da un batteriofago marcato con 32P e in un secondo esperimento da un batteriofago marcato con 35S. Dopo pochi minuti dall’infezione, le soluzioni contenenti i batteri infettati furono prima agitate in un frullatore, in modo abbastanza energico da staccare dalla superficie batterica le parti del virus che non erano penetrate nel batterio (ma non così tanto da provocare la lisi del batterio), poi furono sottoposte a centrifugazione per separare i batteri. Se si centrifuga ad alta velocità una soluzione o una sospensione, i soluti o le particelle sospese si separano secondo un gradiente di densità: i residui del virus (cioè le parti che non sono penetrate nel batterio), che sono più leggeri, rimangono nel liquido surnatante; le cellule batteriche, che sono più pesanti, si addensano in un sedimento che si deposita sul fondo della provetta.
Hershey e Chase scoprirono così che la maggior parte di 35S (e quindi della proteina virale) era contenuta nel liquido surnatante, mentre la maggior parte di 32P (e quindi del DNA virale) rimaneva all’interno dei batteri. Questi risultati suggerivano che a trasferirsi nei batteri era stato il DNA, per cui dal momento che il fago per replicarsi ha bisogno di introdurre all’interno della cellula ospite il suo materiale genetico per poter sfruttare l’apparato batterico di replicazione del DNA, appare evidente che questo materiale genetico deve per forza essere il DNA.
Anche se era stato stabilito che il DNA era il materiale genetico di tutti gli organismi ad eccezione di alcuni virus e fornito alcuni dettagli su come alcuni componenti chimici di base costituivano gli acidi nucleici, rimaneva ancora da decifrare la struttura precisa del DNA cioè come venivano organizzate le catene polinucleotidiche in DNA che funzionava da materiale genetico. Il DNA era composto da una singola catena o da più di una? Se il DNA era formato da due catene come si correlavano chimicamente tra di loro? E come si correlava la struttura del DNA alle varie funzioni come espressione, replicazione e mutazione?
A tal proposito ricordiamo che nel 1949, Erwin Chargaff dimostrò l’esistenza di particolari rapporti tra le quattro basi azotate del DNA (adenina, guanina, timina e citosina), oggi noti come Regole di Chargaff.
Si possono distinguere due regole:
- la prima regola mostra l’esistenza di un rapporto 1:1 tra le basi puriniche (A+G) e le basi pirimidiniche (T+C) contenute nel DNA di una cellula. Il rapporto è costante in tutte le specie, ma per specie diverse le percentuali delle varie basi saranno anch’esse diverse. Questo rispecchia la diversità genetica delle diverse specie.
- la seconda regola mostra che in una molecola di DNA a doppio filamento la concentrazione di adenina eguaglia quella di timina e la concentrazione di citosina quella di guanina (%A = %T; %C = %G). Questo vale per il DNA estratto dalle cellule di tutti gli organismi, anche se considerando organismi diversi le percentuali avranno valori diversi. Questa semplice regola è stata uno degli elementi essenziali che hanno permesso la formulazione del modello di DNA da parte di James Watson e Francis Crick.
Oltre alle scoperte di Chargaff, non bisogna dimenticare che erano note anche altre informazione sulla composizione chimica del DNA. I biochimici sapevano, infatti, che era un polimero di nucleotidi e che ciascun nucleotide era composto da una molecola dello zucchero desossiribosio, da un gruppo fosfato e da una base azotata. La sola differenza fra i quattro nucleotidi presenti nel DNA risiedeva nelle basi azotate: le purine adenina (A) e guanina (G) e le pirimidine citosina (C) e timina (T).
La prova decisiva per riuscire a definire la struttura di questa così travagliata molecole fu, però, ottenuta con la cristallografia ai raggi X, un metodo di indagine utilizzato per stabilire la struttura di macromolecole come acidi nucleici e proteine. Nei primi anni Cinquanta, la biofisica inglese Rosalind Franklin ebbe l’idea di utilizzare questo metodo per studiare il DNA.
Il suo lavoro fu decisivo: senza i dati da lei ottenuti, i tentativi di descrivere la struttura del DNA sarebbero andati a vuoto. A sua volta, il lavoro della Franklin dipese dal successo ottenuto dal biofisico inglese Maurice Wilkins nel preparare campioni di DNA con fibre orientate in modo estremamente regolare (la regolarità della struttura interna è una prerogativa dei cristalli), e quindi assai più adatti a essere sottoposti a diffrazione. Le cristallografie preparate con questi campioni di DNA dalla Franklin suggerirono che la molecola fosse a forma elicoidale, o a spirale.
Franklin, in particolare, mostrò che la molecola di fosfato che fa da impalcatura alla struttura doveva essere sul lato esterno del DNA e che il DNA doveva avere forma elicoidale: una specie di scala a chiocciola. Tuttavia, rigorosa e prudente all’eccesso, decide di non pubblicare nulla prima di avere prove conclusive. Nel 1951 James Watson, biologo statunitense, assistette a un seminario della Franklin ed ebbe l’opportunità di osservare le sue foto e di ascoltarla. Capì che il DNA doveva avere qualcosa a che fare con un’elica. Basandosi su questo, James Watson e Francis Crick, suo collega presso il Cavendish Laboratory di Cambridge, costruirono in una settimana un modellino di DNA. Questo modellino risultò in tre filamenti, il fosforo sul lato interno e le basi azotate che spuntavano fuori dalla molecola. Tale modello venne poi spedito a R. Franklin per un consiglio ma ella lo bocciò come “inconsistente coi dati sperimentali”. Ma pochi mesi dopo alcuni colpi di fortuna ( la conoscenza di M. Wilkins che consegnò loro la famosa foto 51 fatta da R. Franklin e a sua insaputa dove veniva mostrata la forma di un’elica e la dimensione esatta del diametro della molecola del DNA) , di astuzia e di genio ( le scoperte di E. Chargaff ) destinarono a J. Watson e a F. Crick l’opportunità di ricevere il premio Nobel. Lo stesso Watson scriverà in seguito: “Nell’istante in cui vidi
quell’immagine rimasi a bocca aperta. Molti dei parametri vitali dell’elica erano lì “. Anche Crick ammetterà: “Senza quei dati la formulazione del nostro modello sarebbe stata altamente improbabile, se non impossibile.
La fotografia di R. Franklin, la famosa foto 51 che Wilkins mostrò a Watson e Crick, permise di calcolare alcuni parametri dell’elica. Si tratta di una fotografia di diffrazione a raggi X della forma B di fibre di DNA purificato. Gli archi marcati sulla periferia mostravano aspetti della molecola strettamente spaziati che fornivano una stima della periodicità delle basi azotate distanziate di 3,4 A (angstrom) . Il profilo interno di macchie a croce mostrava l’aspetto più grossolano della molecola indicante la sua natura a elica. Il DNA era precipitato con una soluzione concentrata di etanolo e formava delle fibre in cui le eliche si impacchettavano a formare delle strutture simili a cristalli (cristalliti) che potevano essere analizzate mediante diffrazione con raggi X.
Nel 1962, dopo la morte di Rosalind Franklin (a causa di un tumore provocato, probabilmente, dalle alte dosi di raggi X a cui si era esposta nel corso dei suoi esperimenti), Watson, Crick e Wilkins ricevettero congiuntamente il Premio Nobel per la medicina per la loro scoperta. Dal momento che questa si basò essenzialmente sui dati di Rosalind Franklin, ancora oggi esistono pareri molto eterogenei nella comunità scientifica su chi avrebbe dovuto ricevere tale premio.
Quindi, di fatto, il successo di Watson e Crick fu attribuito alla costruzione di un modello che concordava con le informazioni precedenti. Essi ipotizzarono che la molecola del DNA fosse costituita da una doppia elica, cioè da due catene polinucleotidiche spiralizzate con avvolgimento destrorso attorno a un unico asse, connesse tra di loro da legami-idrogeno. Proposero che i legami-idrogeno connettessero tra loro le coppie di basi note per essere presenti in quantità uguali, cioè A con T e C con G. Le risultanti strutture risultano planari, perpendicolari all’asse e di dimensioni identiche (garantendo quindi un diametro costante per la doppia elica, indipendente dalla sequenza delle basi).
Le coppie di basi sono complanari; i desossiribosi giacciono su piani perpendicolari a quelli delle basi Le catene pentoso – fosfato – pentoso – fosfato… sono fortemente anioniche e si devono trovare
all’esterno della molecola a contatto con l’acqua, mentre le coppie di basi, idrofobiche, si impaccano le une sulle altre al centro della molecola, escludendo l’acqua. Avvicinando due filamenti di DNA c’è repulsione causata dalle cariche negative.
Tra le basi che si fronteggiano si formano dei legami idrogeno: 1. Due tra A e T; 2. Tre tra C e G.
Tra le basi si instaurano interazioni idrofobiche che stabilizzano ulteriormente la molecola. Ciascuna catena ha un’estremità 3’ e un’estremità 5’. Le due catene della doppia elica sono disposte in modo antiparallelo in quanto i legami fosfodiesterici che uniscono i pentosi contigui hanno polarità opposte. In altre parole, in corrispondenza di ciascuna delle due estremità della doppia elica, il terminale 5’ di una catena si confronta con il terminale 3’ dell’altra catena. La disposizione antiparallela si rende necessaria in virtù del fatto che, i residui atomici impegnati nei legami a idrogeno fra una purina e una pirimidina, si raffrontano in posizione ottimale se e solo si ha tale configurazione.
Ciascuna elica presenta un residuo nucleotidico ogni 3,4 A lungo la direzione dell’asse e, inoltre, si formano angoli di 36° tra residui adiacenti della stessa catena; in tal modo la struttura si ripete dopo 10 residui su ciascuna catena, cioè dopo 34 A. Oltretutto la distanza tra un atomo di fosforo e l’asse della molecola (per usare un termine dei due scienziati) è di 10 A, per cui i diametro del DNA è 2 nm.
Tutto questo fa capire come l’elevata capacità informativa del DNA si spiega con la sequenza dei nucleotidi. Le due eliche differiscono quindi per polarità, per sequenza e per composizione in basi, ma sono perfettamente complementari, cioè la sequenza di una catena è completamente determinata da quella della catena opposta. Questo significa, come intuirono immediatamente Watson e Crick, che lo specifico appaiamento tra le basi azotate suggerisce un possibile meccanismo di copia del materiale genetico.
Le evidenze sperimentali a supporto del loro modello furono riportate in una serie di cinque articoli pubblicati sullo stesso numero di Nature del 25 aprile 1953 Tra questi articoli figurava anche quello di Rosalind Franklin e di Raymond Gosling, suo collega, che conteneva i dati di diffrazione a raggi X, fondamentale per sostenere il modello. Il numero di Nature conteneva anche un articolo sulla struttura del DNA scritto da Maurice Wilkins, che avvalorava ancor di più il modello dei due scienziati del Cavendish Laboratory di Cambridge.
Sta di fatto che dopo la pubblicazione del suddetto articolo moltissime altre scoperte riguardanti in DNA sono state compiute. Dal meccanismo con cui avviene la duplicazione alla decifrazione del codice genetico (che è a triplette) e alla scoperta di altre forme di DNA oltre a quella descritta da Watson e Crick (forma B), dalla scoperta dei processi di ricombinazione al sequenziamento genico, fino ad arrivare allo sviluppo delle biotecnologie e al progetto “Genoma Umano” che ha determinato il completo sequenziamento del patrimonio genetico umano.
Ad ogni modo, se all’inizio della sua storia, il DNA era una molecola che destava poco interesse, tanto da essere trascurata per molti anni (gli studi sulla sua struttura si concentrarono moltissimo tempo dopo la prima identificazione), oggi è sicuramente centrale nella ricerca moderna e, di certo, le sue potenzialità sono, in larga parte, ancora da scoprire.